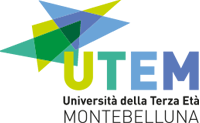programma provvisorio
• Tre lezioni dedicate a Kafka da parte della prof.ssa Savietto del liceo Veronese
• Tre lezioni sulle tecniche narrative da parte della prof.ssa Masiero
• Due lezioni del prof. Cerantola su Luigi Meneghello (autore di un libro su questo autore)
programma provvisorio
• un intervento del dott. Tessari (due ore consecutive) sulla riforma sanitaria (storia e attuazione in Veneto, problematiche attuali)
• un intervento dell’ex sindacalista Giovanni Trinca parte come testimonianza personale, parte sulle politiche di integrazione degli immigrati
programma provvisorio
• Una lezione di due ore consecutive del maestro Antonio Pessetto sulla Turandot (sono 100 anni dalla morte di Puccini)
• Due lezioni della prof.ssa Abiti come prosecuzione di un intervento già iniziato sulla figura della donna nell’arte
• Due lezioni della dott.ssa Di Mambro sull’urbanistica della Roma dei papi
• Tre ore di Ferdy Barbon su “Immagini e simboli nel medioevo”
• Un’ora della dott.ssa Gilli del Museo su un argomento di archeologia da definire
programma provvisorio
• due interventi del prof. Piaia su “Europa, storia e crisi di un’idea”
• un intervento del dott. Davide Tocchetto autore del libro “Vita quotidiana a Gaza”
• due lezioni di Lucio De Bortoli sulle origini storiche della questione israelo-palestinese
• tre lezioni del prof. Andrea Franco sulla storia dei rapporti russo-ucraini
• due interventi del prof. Piaia su “Europa, storia e crisi di un’idea”
• un intervento del dott. Davide Tocchetto autore del libro “Vita quotidiana a Gaza”
• due lezioni di Lucio De Bortoli sulle origini storiche della questione israelo-palestinese
• tre lezioni del prof. Andrea Franco sulla storia dei rapporti russo-ucraini
programma provvisorio
• Due lezioni del dott. Risato sul sangue e il sistema circolatorio
• Due lezioni del prof. Poletti “Pillole di fisica quotidiana” (la fisica applicata ai fenomeni che osserviamo quotidianamente)
• Due lezioni del prof. Flora sull’archeoastronomia e sulle meridiane
• Un’ora della prof.ssa Susanna Brunello sull’ingegneria genetica
• Un’ora del dott. Giorgio Vaccari sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030, in vista di una mostra in programmazione (possibile successiva visita guidata)
• Due interventi del dott. Enrico Martini dedicati alla geomorfologia e alla flora montana
• Due lezioni del prof. Lanza dedicati alle immagini del sistema solare e del cosmo
• Due lezioni del dott. Risato sul sangue e il sistema circolatorio
• Due lezioni del prof. Poletti “Pillole di fisica quotidiana” (la fisica applicata ai fenomeni che osserviamo quotidianamente)
• Due lezioni del prof. Flora sull’archeoastronomia e sulle meridiane
• Un’ora della prof.ssa Susanna Brunello sull’ingegneria genetica
• Un’ora del dott. Giorgio Vaccari sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030, in vista di una mostra in programmazione (possibile successiva visita guidata)
• Due interventi del dott. Enrico Martini dedicati alla geomorfologia e alla flora montana
• Due lezioni del prof. Lanza dedicati alle immagini del sistema solare e del cosmo
programma provvisorio
• ciclo di Giuseppe De Bortoli dedicato a “Libertà, servitù, liberazione”Docente: Gianni
• ciclo di Giuseppe De Bortoli dedicato a “Libertà, servitù, liberazione”Docente: Gianni
• un intervento di Girolamo Vardanega (due ore di seguito) dedicato al Pakistan
• un intervento del dott. Roberto Robazza su “La tavola del contadino” (qual era l’alimentazione dei contadini nei decenni e secoli passati)